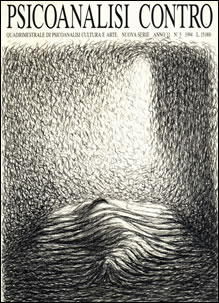II.1 LA MITICA FAMIGLIA
Il bambino inizia la sua esistenza ben prima di venire alla luce; possiamo dire: dall’incontro, nel ventre della madre, dei due gameti, i quali però sono già a loro volta ricchi dell’esperienza che deriva dal rispettivo corredo genetico. La nascita è uno dei momenti più importanti della vita, ma non necessariamente il più importaste: questo dipenderà dalla storia di ognuno. Perciò non credo agli oroscopi, sebbene creda nell’influenza degli astri; perché l’oroscopo è una diagnosi truffaldina che fissa arbitrariamente il momento della nascita anagrafica, come l’inizio della vita individuale.
Torniamo ora al bambino: egli immediatamente si apre al rapporto col mondo. Io non credo nel narcisismo originario: non è vero che, il feto prima e il neonato dopo, siano chiusi nella loro esperienza soggettiva; anzi sono profondamente convinto che siano entrambi aperti alla relazione con l’altro. Attraverso una serie di meccanismi fisiologici intrauterini, oltre che manipolazioni e messaggi dall’esterno, quell’essere, che prima chiamiamo embrione, poi feto e poi bambino, abbandona, fin da subito, il proprio isolamento. Io sono sicuro che l’essere umano accumula, già dal ventre materno, un patrimonio di esperienze. Eppure, in apparenza, questo patrimonio pare perduto. Perché?
Chi ha un bambino di un paio d’anni si accorge di quanto egli sia capace di ricordare, con eccezionali esibizioni di memoria, fatti di cinque o sei mesi prima. Più tardi, però, non resta traccia alcuna di quanto è accaduto nei primi due anni di vita, che sembrano dimenticati. Ciò è vero solo in apparenza e si spiega col fatto che il bambino fatica ad acquisire il senso del tempo: egli vive soprattutto nel presente ed è dominato da esso. Per ragioni fisiologiche e psichiche è infatti caratterizzato da una estrema labilità, che gli impedisce di fissare i ricordi in una successione temporale e di dare loro una struttura. Solo lentamente, il tempo acquisirà poi per lui la caratteristica di movimento dal passato verso il presente e il futuro.
Il bambino diviene col tempo, se ne appropria, e, insieme con il tempo, si appropria anche dello spazio. Quando tende la mano ed indica gli oggetti, ovvero li riconosce, mette in atto una elaborazione personale dei due concetti di spazio e di tempo. Indicare implica, per il bambino, percepire l’oggetto desiderato come lontano da sé spazio-temporalmente: “Io indico quell’oggetto che desidero, ma che è lontano, perché impiega tempo a percorrere lo spazio che lo separa da me e dal soddisfacimento del mio desiderio. Io quindi tendo le braccia oppure vado verso di esso: mi muovo nello spazio per andare, nel tempo, verso l’altro.” Così il bambino impara a desiderare e a vedere procrastinato il soddisfacimento del proprio desiderio, prima che possa realizzarsi, nello spazio e nel tempo.
Dopo aver imparato a collocare l’altro nel tempo e nello spazio, il bambino passa a domandare: “Cosa è quello?” I bambini non domandano mai “se” una cosa c’è, se quel cavallo esiste, ma domandano che cosa quel cavallo è. Potremmo dire, con Rosmini, che, nel bambino il concetto di “essere” è innato, mentre il concetto sii “non essere” forse non verrà acquisito neanche dall’adulto e resterà una bizzarria filosofica. L’uomo tutt’al più riesce ad immaginare l’ “essere diversamente”, ma non il non essere. Successivamente, inizia per il bambino l’epoca dei “perché?” Una richiesta continua ed ossessiva, che però nasconde qualcos’altro, oltre al desiderio di far arrabbiare i genitori.
A questo punto, egli ha compreso il significato della diagnosi: “il tempo, lo spazio, la cosa e il perché”. Contemporaneamente egli assimila i precetti morali (che non sono altro che la modulazione dei desideri nel tempo: alcuni verranno soddisfatti, altri procrastinati, altri rifiutati). Incomincia la dialettica tra il “devi fare” e il “non devi fare”. Con l’uso organizzato del linguaggio sopravviene poi il tempo del “nome delle cose”, con il quale si instaura un gioco che non si fermerà più.
Anche “madre” è una parola, che è il coagulato di una descrizione e che esprime una diagnosi. “Madre” non vuol dire soltanto: “colei che ha partorito”; ma implica tutta una serie di definizioni che hanno un significato culturale. Ogni donna avrà un suo modo di essere madre e di trasmettere questo significato. Le donne diventano madri non quando partoriscono, ma quando, ancora bambine, si trovano ad avere in mano una bambola; già da allora, infatti, si preparano ad un modo ben preciso di essere madri. Sbagliando, la nostra cultura dice ancora oggi quello che diceva anticamente, cioè che la donna ha il grande privilegio (o la grande condanna) di “generare”, confondendo questo termine con “partorire”. La donna, come ben sappiamo, non genera e non ha più parte dell’uomo nella generazione. Nella specie umana, la femmina e il maschio, insieme, generano. La donna è prima una gestante e poi una partoriente. Questo ha un significato ben preciso, che risulta evidente dalla considerazione che si ha per quel ventre che per nove mesi è gonfio di una vita altra da sé. Dalla bambola al ventre gonfio, al modo in cui crederà di “recitare” il proprio ruolo quando manipolerà il suo bambino, ogni donna avrà un diverso modo di essere madre e di trasmettere questo significato. Esiste “quella madre” perché c’è stata “quella bambola”. Le bambole cambiano nel tempo e con esse cambia il concetto di madre e quello di figlio.
Il maschietto non viene invece educato a diventare padre, attraverso un giocattolo emblematico, che equivalga alla bambola. Tutt’al più gli si parla del padre e dei padri e gli si prefigura la possibilità di diventare un giorno a sua volta padre. Indirettamente trova in giochi come quello del marito e della moglie la possibilità di immaginarsi un futuro ruolo paterno. Il maschietto si trova a costruire la capanna o casetta in cui fa abitare i figli immaginari e la compagna di giochi che recita il ruolo della sposa. Il suo interesse è però concentrato su altri giochi, di avventura, di prestanza fisica, di lotta e di guerra. Le fiabe e le rappresentazioni teatrali e cinematografiche sono gli strumenti privilegiati sui quali si forma l’idea che i bambini si fanno dei loro futuri ruoli. Al maschio viene presentata un’immagine del padre con cui identificarsi e su cui proiettare sogni e fantasie, anche sessuali; su cui pure sfogare aggressività e desideri di morte; ma, in ogni caso, quasi mai esplicitamente gli vengono date indicazioni sul modo di prepararsi a quello che dovrà essere anche il suo ruolo. Troppi padri si sottraggono ad una partecipazione attiva all’educazione e ancora oggi, dopo il concepimento, abbandonano quasi completamente la cura e il pensiero dei figli alla madre e alle altre eventuali donne di casa, subendo senza saperlo un’ulteriore castrazione, che riguarda loro, ma anche i figli maschi. Freud dice che il bambino che la donna ha partorito è per lei un sostituto del fallo che non ha. La mia esperienza clinica mi conferma che spessissimo i maschi percepiscono questa appropriazione del figlio da parte della donna come castrazione supinamente accettata. I tribunali, nelle cause di separazione tra coniugi, affidano quasi sempre i figli alla madre, anche per la pigrizia e la vigliaccheria dei padri. È recente la figura del padre che lotta per affermare il suo diritto alla cura del figlio. È un diritto che gli compete. Purtroppo gli stereotipi del padre e della madre imperano nell’inconscio sociale ed individuale: il triangolo edipico (o il poligono) continua ancora ad agire sulla rappresentazione famigliare. Non tutto è semplice come aveva creduto Freud o come credono troppi teorici sociali della famiglia. Ancora oggi, però, la convenzionale immagine persiste dando sicurezza, da una parte, in quanto costituisce punto di riferimento collaudato, e confermando dall’altra una povertà di schemi affettivi. Per fortuna non s’è persa l’eco degli antichi miti e la storia di Edipo e di Giocasta si intreccia con quella di Eteocle e Polinice, Ismene ed Antigone e la rappresentazione non si ferma. Questo frammentario tentativo di diagnosi dei ruoli di padre, di madre e di figlio che ho qui esposto è l’inizio di una serie di diagnosi che cercherò di esporre in seguito, ma so bene che l’inizio non è stato né il padre né la madre.
II.2. LONTANO DA EROS
La follia è una presenza costante; il linguaggio stesso ne esprime la quotidiana realtà: “ma sei pazzo!” è un modo di dire, un intercalare consueto. Pazzo deriva dal latino “patiens” = che soffre; matto dal tardo latino “mastus” = ubriaco; folle, ancora dal latino “folis” = pallone pieno di vento. Una convinzione che è maturata in me, affrontando clinicamente il campo della follia, è quella che non abbia senso la distinzione comunemente operata dai trattati di psichiatria quando distinguono tra psicosi funzionale, in cui sarebbero disturbate le funzioni psichiche, senza che sia evidenziabile un’alterazione organica, e psicosi con base organica, in cui è evidente una lesione o un’alterazione del sistema nervoso. Credo che questa divisione sia metoclologicamente scorretta, in quanto tutte le affezioni della psiche hanno a mio avviso un riscontro organico. Non credo che la psiche sia qualcosa di staccato dal corpo, sono invece convinto che esista una realtà unica, somatopsichica, che io definisco “persona”, alla quale deve essere riferita ogni modificazione del comportamento. Per questo non sono contrario, per principio, all’uso dei farmaci e anche degli psicofarmaci. Il tipo di intervento farmacologico estremamente mirato sulla persona deve comunque soltanto essere un momento dell’azione terapeutica. Ho detto che la psicosi si instaura quando si sovrappongono e si chiudono le due difese fondamentali, al punto che non è neppure più possibile distinguere se siamo in presenza di una struttura prevalentemente sadomasochistica oppure narcisistica. Chi ha avuto a che fare con i cosiddetti “pazzi” si sarà accorto che i deliri e le allucinazioni si sostituiscono alla realtà, tentando di abolirla narcisisticamente e nello stesso tempo di distruggerla sadomasochisticamente. Il mondo è diventato pieno di fantasmi, Eros è troppo lontano, anche se non del tutto assente.
Le difese in quanto tali hanno la funzione di difendere dalla relazione con l’altro, al limite persino con noi stessi. Ogni relazione si mette in opera necessariamente in uno spazio ed in un tempo. Nelle psicosi i rapporti temporali risultano molto più distorti di quanto già normalmente avvenga. Lo psicotico percepisce i fantasmi del proprio passato come se fossero presenti e reali: è qui ed immagina di non essere qui, vive oggi e si pensa in un lontano allora. Ricordo una ricoverata in ospedale psichiatrico che “andava indietro” di cinque giorni.
La psicosi si esprime fondamentalmente attraverso due moduli: la depressione e la mania; tutte le altre pseudo-classificazioni (isteria, schizofrenia, etc:) sono solo storielline piene di contraddizioni. La depressione è forse la forma più grave di malattia mentale: significa infatti sprofondare in una condizione di negazione del mondo e della stessa vita. Prodromi di questa situazione possono essere sintomi di patofobia o addirittura di ipocondria. Una importante caratteristica del depresso è la profonda disistima di sé, la tendenza ad autoaccusarsi. La depressione è a mio giudizio una parodia della morte, che può condurre alla condizione di arresto psicomotorio e all’immobilità del catatonico, che sembra morto senza esserlo, che vuole pensarsi morto senza riuscirci davvero perché la morte non è un concetto rappresentabile dalla mente dell’uomo vivente. Nonostante le apparenze, la depressione non è una forma soltanto sadomasochistica, anche se esprime molto masochismo con l’esasperato gusto per la propria sofferenza e molto sadismo per la enorme capacità di ricatto ché il depresso opera nei confronti degli altri. Un ricatto di sadismo infinito perché rifiuta ogni risposta, perché disprezza e vanifica ogni soccorso. L’aspetto narcisistico della depressione si esprime con la concen-trazione sul proprio corpo che genera dapprima la condizione di patofobia, e poi con il delirio di corruzione del proprio organismo, tipico dell’ipocondria.
La mania è invece un modo di reagire, opposto a quello autosvalutante della depressione: ci si esalta fantasticando di essere .grandi personaggi (non solo Napoleone), ci si illude di essere al centro dell’interesse universale, per lo più con forme di delirio persecutorio. Anche la mania ha la doppia modalità: narcisistica – il maniaco è interessato soltanto a se stesso – o sadomasochistica, nel gusto di essere persecutore o di credersi perseguitato. La paura della follia è una tra le più diffuse e può esprimersi con uno stato di sottile e permanente angoscia, oppure con un’esplosione di fobia. Molti arrivano dallo psicoterapeuta proprio per sfuggire a questa paura che li attanaglia e che assume a volte contorni terrificanti inducendo comportamenti che disturbano la vita quotidiana. La mente è disorientata,le idee sfuggono di testa, la memoria non c’è più; a volte si giunge al tenore di compiere gesti inconsulti. La paura della follia nasconde anche sottili desideri. In ogni caso posso dire che la paura della follia non è necessariamente un prodromo della follia stessa: solo una parte di coloro che hanno questa paura rischia davvero la follia.
II.3. IL GIUDIZIO SOCIALE
Quando dico che non esiste per me differenza sostanziale tra psicosi funzionale e psicosi con cause organiche non voglio ovviamente negare che queste ultime possano essere riscontrate, solo che non mutano la natura della psicosi in sé, che è sempre un disturbo della persona. Inoltre agiscono come cause determinanti della follia i giudizi del gruppo sociale. La storia di una follia è sempre quella di una persona, del suo rapporto con la società e l’ambiente, ogni volta diversa da ogni altra. La necessità di avere parametri non autorizza però clinici, filosofi e scienziati ad applicare sulle persone schemi rigidi di classificazione che sono sempre inadeguati e devianti.
Vorrei portare un esempio di disturbo psichico che è una storia personale e, nello stesso tempo, un esempio di quanto agisca il giudizio di una cultura e di un ambiente sociale.
Avevo in analisi un ragazzo che, per ragioni di lavoro ed anche per il punto delicato raggiunto dal comune lavoro analitico, decise di interrompere l’analisi e di trasferirsi in un’altra città. Prima di operare quella che io consideravo come una vera e propria fuga mi chiese di dare il suo posto alla sorella, desiderosa di iniziare un lavoro di psicoanalisi. Sebbene io accetti solo pochissimi pazienti per dedicarmi con maggior libertà al lavoro didattico e teorico, tuttavia decisi di dare alla sorella, che al primo incontro era riuscita a destare in me interesse e simpatia, le ore di lavoro che prima dedicavo al ragazzo. Nel lavoro delle prime sedute venne fuori una personalità sensibile, capace di cogliere il mondo e di lasciarsi penetrare dalle sensazioni; coglievo però nel suo modo di percepire la realtà qualcosa che mi faceva paura. Mi parlava come se fosse sempre un pochino lontana da me e dalle cose; era piuttosto prevedibile nella sua voglia di essere originale: amava l’arte romanica, preferiva la scultura alla pittura, detestava i poeti romantici ai quali preferiva i lirici greci e Dante. Risultava moralmente rigida e persin troppo scrupolosa e corretta. Mi dava un po’ fastidio, ma me ne ero anche innamorato. Aveva difficoltà notevoli di rapporto con gli altri, si sentiva depressa e non riusciva più a studiare, frequentava una facoltà scientifica che detestava. Aveva frequenti dolori alla nuca e alle spalle. In una seduta mi raccontò un sogno che dette una svolta all’analisi. Prima mi disse che amava la montagna, ma, curiosamente, le piaceva solo salire, mentre la angosciava dover intraprendere la discesa, la faceva stare male vedere davanti a sé il precipitare delle vallate. La notte precedente aveva appunto sognato di trovarsi da sola in montagna e di aver dovuto iniziare da sola la discesa verso la pianura, ma la paura era diventata angoscia che alla fine l’aveva fatta urlare fino a svegliarla.
Mi disse: “Diventerò pazza? Ho tanta paura di diventare pazza.” Quello fu per me un campanello d’allarme. Qualche tempo dopo incominciò con insistenza a chiedermi se io posteggiassi appositamente l’automobile sotto casa sua e poi prese ad insistere chiedendomi cosa volessi significarle facendo ciò, fino a che la cosa si estese rivelando una mania persecutoria accentuata le cui origini potei rintracciare con molta fatica. L’anno precedente aveva avuto un fidanzato, non bello, povero e di poco successo, ma con cui si era trovata bene fino a che la sorella non si era messa con un giovane bello e intelligente, aitante e sicuro di sé. Dopo aver per un po’ di tempo umiliato il suo ragazzo tiranneggiandolo e costringendolo a continui confronti con l’altro, decise di lasciarlo, ma la cosa le procurò rimorso. Mesi dopo, in campeggio, fece amicizia con una ragazza molto bella, di cui l’avevano colpita soprattutto due enormi orecchini di plastica bianca che quella indossava spesso. Raccontò alla nuova amica la sua fallita storia sentimentale e trovò comprensione e solidarietà contro il comune nemico identificato nel maschio perfido e meschino, nei confronti del quale si può reagire solo pagandolo con la stessa moneta, senza scrupoli di sorta. In realtà quell’apparente solidarietà le fece nascere sentimenti di colpa, perché pareva confermare, al di là delle intenzioni, la cattiveria egoistica del suo comportamento. Una sera, sulla spiaggia, fumò insieme con gli altri marijuana e si sentì cogliere dai grandi interrogativi sull’infinito, le stelle, l’universo e poco a poco montò in lei l’angoscia accentuata da una spaventosa tachicardia. Si sentiva svenire e in lei vorticavano le domande senza risposta: “Dove finisce l’universo, cos’è lo spazio, chi sono io?” La ragazza con gli orecchini bianchi era china su di lei e lei era impressionata da quel suo viso incorniciato da quella chincaglieria esageratamente grande. Fu necessario l’intervento di un medico. Dopo pochi giorni le giunse la notizia che il ragazzo che aveva lasciato aveva avuto un incidente d’auto. Se ne sentì colpevole tormentandosi per giorni finché una sera provò ancora a fumare “erba” con il risultato della volta precedente. Poi crisi di panico vere e proprie incominciarono a scatenarsi senza che lei fumasse. Poco a poco incominciò a pensare che la ragazza dagli orecchini che fingeva di aiutarla fosse in realtà una sua persecutrice: prese ad odiare lei e la sua mania di prendere il sole a seno scoperto, a odiare le sue mammelle e i suoi orecchini. Tornata a casa credette di sentir raccontare alla radio il suo caso in una trasmissione di cui ero il conduttore. Per questo aveva insistito per venire da me. Il delirio precipitò in un vortice in cui io, il fratello, la ragazza con gli orecchini e il fidanzato facevamo parte di un’unica organizzazione, che faceva esperimenti su di lei, che le metteva microfoni nascosti ovunque. La famiglia cercò ad un certo punto di allontanarla dall’analisi e la affidò ad uno psichiatra che intervenne con dosi eccessive di psicofarmaci, aggravando la situazione. Per fortuna potei riprendere il lavoro con lei, che per lungo tempo mi identificò col nonno, che l’aveva rifiutata perché femmina e da quel punto procedemmo. Una storia come un’altra dunque, ma unica nel suo sviluppo, condizionato anche dal giudizio che un gruppo dà sull’essere maschio e femmina, dalla cultura che esalta la droga ed impone l’esibizionismo sessuale e via dicendo.
La storia della depressione ha nella nostra cultura radici antichissime: la colpa originaria, il peccato originale, non è un’invenzione della cultura ebraica o del cristianesimo. Nonostante l’avviso opposto di certi grecisti d’accatto, la cultura ellenica aveva in sè questo concetto. Platone lo evidenzia chiaramente nella Apologia di Socrate. L’origine di questo senso di colpa derica va, io credo, ai Greci dal loro tentativo di ribellarsi alla cultura matriarcale che avevano avuto alle spalle. Mentre i Greci si sono sottratti al sentimento della colpa appellandosi al Fato, dal quale non ci si può liberare, ma di cui non si è responsabili, i Cristiani sono invece soggiaciuti al sentimento di colpa, che il depresso vive fino in fondo, fino a desiderare la distruzione di sé. La società moderna ha elaborato due tipi di fantasie reattive per difendersi dalla depressione che distrugge la “scienza” e la “religione”. Di questi reattivi sono però permeate anche le forme più gravi della follia: dalla scienza deriva la fantasia sui macchinari onnipotenti di controllo del pensiero. Dalla religione derivano le ossessioni diaboliche, le presenze invisibili, le possessioni, le persecuzioni dall’al di là.
Noi non possiamo negare oggi la realtà della follia, ma dobbiamo vederla in tutti i suoi aspetti anche di demenza, stupidità, cattiveria, di cui certo sono responsabili anche l’insufficiente mielinizzazione che ingenera l’oligofrenia, o l’arteriosclerosi che ristupidisce, ma che coesistono con le ragioni sociali e culturali. Questo vale per il ragazzetto di sinistra che incomincia a non lavarsi per ragioni ideologiche e poi cade vittima di una catatonia depressiva che lo fa languire nella sporcizia e nel fetore fino alla morte. Per lo scienziato che insegue la sua teoria in solitudine e perde poco a poco il contatto con la realtà affondando in un delirio di carta e di segni senza senso in un padiglione di manicomio. Per la ragazza che è stata terrorizzata da una mammana dalla quale è stata condotta a forza dai parenti per un aborto e che ora è da anni ricoverata col ventre gonfio, da cui attende che nasca Gesù, che non vuole nascere in un mondo così spaventoso. Quali sono i pazzi? Coloro che impongono i comportamenti o coloro che li subiscono?
Prima si diceva che il pazzo fosse un posseduto e non sempre la cosa fu valutata in senso negativo, anzi grande rispetto circondava e circonda gli sciamani siberiani; nella Grecia antica le crisi comiziali erano ritenute segno di predilezione degli dèi; ma anche in forma negativa comunque la possessione è stata a lungo ritenuta causa della follia. A partire del Settecento si forma la convinzione che la follia sia un vizio o una malattia. Il vizio in particolare può essere curato attraverso la redenzione morale del malato; così gli Illuministi pensano all’ergoterapia che recupera l’individuo alla società. La malattia invece libera il pazzo da ogni responsabilità morale e quindi la scienza medica del neopositivismo borghese affronta lo schizofrenico con lo stesso spirito con cui affronta il gastritico, trascurando completamente il problema delle cause e del rapporto. tra individuo e società. Questa demenza verrà superata solo dall’antipsichiatria contemporanea che negherà addirittura la malattia addossando ogni responsabilità alla società, incapace di assorbire e capire la diversità e che anzi ha la colpa di reprimere la libertà che è insita nella follia, tutto ciò trascurando completamente la realtà del dolore e della perdita di autonomia di chi affonda nella psicosi. A questa concezione non è estranea un’anima poetico-lettararia che da sempre, in malafede, esalta la poeticità della follia, per non doversi porre il problema della sua cura.
II.4. UNA PICCOLA LUCE
La follia è dunque una tra le maschera più inquietanti della nostra cultura ed è sempre stata considerata, da Ippocrate in poi, come malattia o possessione o colpa, che comunque domina l’individuò che può essere curato, relegato o punito dalla società che se ne deve occupare per guarirlo o per difendersene; il folle è come quasi tutti gli altri malati un oggetto su cui e per cui gli altri decidono.
La psicoanalisi si è ribellata a questa concezione, affermando il principio che la terapia deve necessariamente coinvolgere il malato; la gestione della terapia deve essere comune del terapeuta e del paziente stesso. È il concetto che Freud enuclea progressivamente, dopo aver abbandonato la pratica dell’ipnosi degli inizi proprio perché passivizzava troppo il paziente; anche se egli personalmente non pensò mai di affrontare con il suo metodo terapeutico le psicosi.
Questa a me pare una svolta di grande significato. Bisogna rispettare le scelte del malato e non si ha il diritto di guarirlo con la violenza. Tutto ciò però implica una sua partecipazione che può essere letta come una responsabilità o una colpa: torna il problema della libertà di scelta, del libero arbitrio, di fronte al quale si trova anche il terapeuta. Di fronte ad una concezione, secondo me giusta, che vede il disturbo psichico, contemporaneamente, come una colpa e come una malattia, il terapeuta deve operare non espropriando il paziente dei suoi diritti, ma coinvolgendolo nella cura. Si tratta di avere l’atteggiamento del “doppio come se”. Il terapeuta deve comportarsi come se fossero valide le due ipotesi: deve rispettare il malato, considerandolo capace delle proprie scelte; ma allo stesso tempo deve tenere conto che quella libertà ha subito, a causa di molteplici ragioni: personali, sociali ed ambientali, uno scacco che ha provocato la malattia, che significa anche progressiva perdita della capacità di decidere. Il terapeuta diventa così il filosofo che guida il paziente sull strada della riappropriazione di se stesso e di un mondo di valori comuni.
Un grave errore di molti psichiatri e psicologi è quello di credere che la scoperta delle cause di un disagio psichico significhi aver risolto il problema. Io credo invece che questa conoscenza non sia che una piccola luce che contribuisce solo in parte a leggere con più chiarezza la malattia. È invece molto più importante scoprire come una persona convive con essa e come l’ambiente e il gruppo reagiscono: qui si può radicare una giusta impostazione somato-psichica che interessa tutta la medicina e non solo quella a base psicologica. I testi di psicosomatica sbagliano quando dicono per esempio che l’asma deriva da un pianto represso, che la gastrite ha origine da uno stato d’ansia, l’ipertensione arteriosa è generata da un conflitto e così via: la realtà è più complessa e i sintomi si evolvono con la persona e il suo ambiente; le cause e concause sono sempre risultanti di relazioni intersomato-psichiche e sociali per cui non può esistere una tabella delle corrispondenze tra disturbo organico e causa psichica, data una volta per tutte.
Quello che voglio dire è che non è possibile dare parametri diagnostici validi universalmente: ogni persona ha una storia irripetibile che non può essere trascurata; inoltre troppo spesso l’atteggiamento del terapeuta determina l’evoluzione della malattia, come la determinano la reazione del gruppo sociale e le condizioni ambientali. Un’educazione troppo liberale può ottenere risposte reattive altrettanto negative quanto un’educazione repressiva. Un atteggiamento di emarginazione può determinare il fissarsi di comportamenti antisociali, ma lo stesso risultato potrebbe avere un atteggiamento di iper-valutazione, etc.
Ogni persona è frutto di una situazione che precede la sua stessa comparsa sulla terra, perché nasce dall’unione di due semicellule, i gameti, frammenti di materia ricchi di cromosomi e di geni che mandano le loro informazioni all’embrione, che si deve adattare all’habitat che trova nel ventre della madre, la quale ha le sue caratteristiche individuali, appartiene ad una classe sociale e vive in un ambiente determinato; la gestazione si conduce passando attraverso esperienze di benessere o di malattia, di violenza o di amore, di angoscia o di allegria. Quando nasce, l’individuo è già ricco di un’esperienza secolare. Non esistono due persone identiche fin dal concepimento e ogni persona è unica nell’eternità.