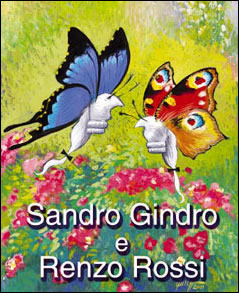A Palazzo Braschi viene rappresentata in questi giorni la mostra Impronte dedicata all’opera di Paolo Guiotto. I suoi lavori sono partiti come tentativi pittorici a cui la pittura si è ribellata, trasformando quasi indipendentemente dalla volontà dell’artista, la bidimensionalità prima in tridimensionalità e poi ancora in ricerca: indagine sul senso del vuoto e del pieno, dello spazio e della concretezza. Lungi da noi l’idea di affrontare un’altra volta il dibattito obsoleto del rapporto tra disegno e scultura: ci ripugnano ormai queste vecchie querélles assolutamente inutili che lasciano il tempo che trovano. Ogni essere umano, quando si vuole esprimere, sceglie quello che gli è più vicino. Tutto il resto è soltanto chiacchiera accademica.
In questa sua antologica Guiotto ha costruito con le mani, con una irresistibile sensualità materica, il suo bisogno di dire, di parlare del mondo, dell’universo e delle piccole cose; pascoliano e dannunziano allo stesso tempo. La materia è per lui sempre presente, nella sua concretezza sensuale, col desiderio di esistere e di farsi percepire. Noi non pensiamo che la scultura si possa solo vedere: si può anche toccare;
ripercorrendo con le mani il lavoro sensuale dell’artista e il suo bisogno di sentire e di farsi sentire.
Qui il mondo è rappresentato con una cifra classica ed universale; quello degli antichi Eleni e le piramidi degli Atzechi si mescolano a considerazioni filosofiche contemporanee: il mondo è questo, potrebbe anche essere altro. E poi ancora: tenere connotazioni quotidiane legate all’amore, al desiderio, alla fantasia. La materia si raggruma: il bronzo, il marmo e il segno grafico addirittura si estrinsecano in un’esigenza li concretezza. La parola è oltre il gesto, la una sua solidità innegabile e può essere sintetizzata in una lampadina, una scalinata, una meridiana, nell’articolazione di una mano.
Paolo Guiotto si offre all’approccio come un esoterico, di quelli che dell’universo leggono i segni affollati e molteplici in un’ansia di comprensione che non può trovare appagamento nel breve volgere di una vita o di un’epoca e di questa condizione è testimone una grafica sovrabbondante e babelica, anche quando si traduce in cabale cesellate e scavate sulla quadrangolari superfici di bronzo di Spaeculum Aevi oppure di Architetture di primavera; ma poi il suo umanesimo si sublima nei marmi bianchi di Oreste ed Elettra de La Luna o La Terra, nel nero maschile de Il Sole o il niveo corpo di Mimi il cui antropomorfismo, sempre sensuale, si carica di forza simbolica, nel bisogno di chiarire l’intreccio del gioco incessante e pericoloso tra il maschio e la femmina. La mia mano nella mano del poeta è un autentico monumento alla memoria di una voce che ancora sorregge lungo un cammino che l’assenza del compagno rende così periglioso.
Il Crocifisso per la chiesa di S. Antonio ad Assago dà di questo umanesimo l’espressione religiosa e dolente; mentre Il corpo assente grida senza pudore il dolore per la presenza che si è dispersa forse per sempre, per l’abbraccio di un amore che è stato vivo e che ora è solo ricordo che non può essere distrutto per quanto lancinante. Non è comunque, l’opera di Guiotto, esauribile in un autobiografismo per quanto nobile; ma si fa comunicazione per chi abbia in sé voglia di ascoltare o bisogno di parlare.