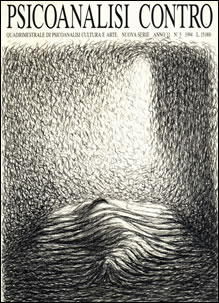La cultura del potere cerca dal suo canto di strumentalizzare ogni forma espressiva, da qualunque parte essa sorga e qualunque istanza cerchi esprimere.
La cultura popolare non è stata, quindi, la cultura degli oppressi che parla di libertà e di liberazione; tutt’al più è successo e può succedere che dalle oscure profondità di un malessere quasi inconsapevole sorgano dure immagini di rivolta, mescolate, però, sempre, a considerazioni e pensieri che parlano di rassegnazione e di accettazione, seppure amara.
Il teatro in genere, non solo quello popolare, ha avuto, sempre, come suo argomento privilegiato, la lotta del bene contro il male 0, meglio, dei buoni contro i cattivi. La cosiddetta cultura popolare, essendo, come ho detto, soprattutto, teatro, ha espresso un’infinità di storie incentrate sulla lotta tra i buoni e i cattivi. Di rado, però, questa lotta ha avuto il significato di lotta per la giustizia, intesa in senso vasto e collettivo; per lo più, si è trattato di dimostrare che il singolo cattivo deve perdere, e allora sono tutti contenti; oppure, in un accesso masochistico, è il singolo buono che viene sconfitto, e allora tutti sono tristi. È più un meccanismo compensatorio che una reale volontà di ribellione, sebbene, per fortuna, talvolta, serpeggi anche questa.
Io penso, tutto sommato, che potremmo ridurre tutta la nostra cultura, sia quella prodotta dai padroni che quella balbettata ambiguamente dai servi e dai mezzi padroni, ad una infinita variante dell’istanza del teatro.
La filosofia e la scienza, nel tentativo di rispecchiare il mondo, non fanno altro che rappresentarlo e l’arte, non importa se attraverso suoni, immagini o parole, racconta sempre una storia. Nella filosofia, nella scienza e nell’arte la mente umana ha sempre bisogno di ritrovare i buoni e i cattivi. La filosofia e la scienza, che sono più narcisistiche fanno sempre vincere i buoni, cioè quel simpatico personaggio che si chiama verità.
Nell’arte si annidano e si manifestano con maggior precisione le istanze sadomasochistiche; i buoni talvolta soccombono; ma la rappresentazione è sempre la stessa.
Potrebbe sembrare che io sia caduto in una contraddizione perché, prima, ho detto che l’arte popolare è in gran parte conservatrice e permeata dai valori della classe dominante, poi, dico che ogni espressione culturale esprime la lotta tra il bene ed il male. Se così fosse, bisognerebbe riconoscere nella cultura popolare un profondo desiderio di rinnovamento, di ribellione e di giustizia.
Io ritengo, invece, che l’espressione popolare così succuba e condizionata da coloro che la dominano, accetti i principi di bene e di male, di giusto e di ingiusto, che le vengono imposti, li faccia suoi e li sostenga. Ho detto anche che tutta la cultura si esprime attraverso la rappresentazione. La cultura propone una visione del mondo, questa visione è sempre un’interpretazione, quest’interpretazione consiste nel proiettare al di fuori i desideri e i bisogni dell’uomo.
La realtà è la mia ipotesi di realtà; cerco di costruire una realtà in cui sia possibile progettare la realizzazione dei desideri che mi sento dentro. Il male è ciò che si oppone ai miei desideri; i miei desideri stessi sono il bene. I desideri e i bisogni sono molti, spesso in opposizione tra di loro; ecco perché la visione del mondo è così articolata e contraddittoria.
Io sono il terreno sul quale i miei desideri combattono; questa lotta la voglio vedere anche fuori di me, perché sento che soltanto attraverso il fuori di me i miei desideri acquistano un significato.
Proviamo ad immaginarci assolutamente soli, aventi come unica caratteristica quella di essere vivi: la nostra mente non ce la fa. La vita è costitutivamente relazione. Possiamo, al massimo, immaginarci fluttuare nello spazio, possiamo immaginare i nostri gesti liberi dal vincolo della gravità, possiamo vederci muovere con piacevoli guizzi; però, abbiamo pur sempre immaginato noi stessi immersi in qualcosa che sta fuori di noi; ma che fa parte di noi; o meglio: noi riusciamo a percepirci come viventi soltanto in relazione a questo vuoto e a questo spazio in cui abbiamo immaginato di star piacevolmente sospesi. Non credo neppure che riusciamo ad immaginare un vuoto e uno spazio assoluti: se noi descriviamo a noi stessi lo spazio deserto in cui abbiamo immaginato di trovarci, ecco che ci accorgiamo che questo non è altro che lo spazio cosmico; così come lo abbiamo immaginato da bambini; oppure lo assimiliamo all’idea di un grande mare e le nostre braccia e le nostre gambe sentono la fresca consistenza dell’acqua. In un’unica espressione, potrei dire che anche se volessimo immaginarci soli in un luogo deserto noi costruiremmo, noi stessi e le nostre immagini, in relazione con questo vuoto deserto, che sarebbe, oltretutto, percepito da noi con caratteristiche palpabili e precise.
Io sento di non essere altro dalla mia esperienza. Non voglio fare un discorso di forma, di io, di contenuto e di esperienza; voglio solo dire che io sono la mia esperienza e la mia esperienza si costituisce nella relazione tra l’io, che a sua volta non è altro che un insieme di relazioni, e un non io, oppure un oggetto, come siamo stati abituati a chiamarlo, che però non è altro se non la situazione stessa di relazione, o la situazione esperienziale.
Possiamo distinguere due momenti fondamentali del progetto esperienziale: il primo è il momento della relazione e basta; il momento in cui i nostri desideri ci formano come esseri relazionati; e in questa situazione la frustrazione del desiderio, e tutto ciò che ne consegue, ha la caratteristica dell’immediatezza, quasi del non voluto. Il secondo momento fondamentale è quello in cui l’esperienza viene oggettivata viene raccontata, nel tentativo di essere capita; in questo momento l’esperienza viene rappresentata, Il mondo in cui l’individuo agisce diventa teatro. Spesso la nostra vita, nei sogni, viene raffigurata con l’immagine di una sala di teatro o un palcoscenico; in questo n:omento l’uomo vive e recita un copione che egli stesso si è scritto, o che ha creduto di scrivere.
Vico diceva che è possibile comprendere, fino in fondo, soltanto ciò che si è prodotto direttamente: l’uomo non potrà mai comprendere la natura perché essa non è una sua creazione, l’uomo può comprendere la storia perché l’ha costruita egli stesso. Io non credo che l’uomo sia più direttamente creatore della storia che della natura; però so che l’uomo racconta a se stesso la propria storia, nel tentativo di comprenderla; e non solo: con beneplacito di Vico, direi che l’uomo racconta, oltre che la propria storia a se stesso, anche la storia dell’universo, a sé e agli altri; la storia dell’universo intero: del sole e delle formiche. Tutto diventa un grande teatro in cui l’uomo spera di essere l’autore e il regista, oltre che l’attore principale, il protagonista, beninteso.
Ma l’uomo non racconta la storia della realtà solo per riuscire a capirla, la racconta anche col desiderio di controllarla e dirigerla. Se e vero che egli scrive il copione deve essere anche vero che può controllare gli avvenimenti e determinare il finale.
La vita, perciò, diventa meno prevedibile; tutto accade come sulla scena; il copione, tutto sommato, protegge da un’inserzione troppo massiccia dell’ignoto. Ciò che comunemente viene chiamato « cultura» non è altro, secondo me, che la rappresentazione. L’uomo e il suo mondo vengono rappresentati dalla cultura, da quella dei padroni come da quella dei servi.
Arrivati a questo punto del mio discorso, potrebbe sembrare che io abbia voluto dire: «Vi è un momento primo originario (l’infanzia?), in cui l’essere umano si costruisce come relazione e tenta di vivere i propri desideri e un seguito (cronologicamente concepito) in cui l’uomo riflette sulle proprie relazioni, sulle proprie esperienze e tenta di inserirle in una scena organica, rappresentando la vita e tutto ciò che entra a far parte della sua vita». Questo secondo momento sarebbe la cultura. Io, però, non volevo dire affatto questo.
Secondo me, questi due momenti non hanno una sistemazione cronologica. Io voglio dire che l’uomo è i propri desideri; e si struttura nella relazione con l’altro perché questa è la direzione dei desideri. Perciò non vi è un momento, o dell’infanzia, neppure la più remota, o della vita interiore, in cui l’Io sia identico a se stesso e coincida pienamente con il sé e, in seguito, un istante successivo in cui questo Io desideri e si proietti fuori di se stesso, progettando. Io affermo che l’essere umano è questo progetto: in principio non c’era altro. Il secondo momento non realizza istanze e bisogni dell’età « adulta ».
Il bisogno di rappresentare è presente fin da subito nell’essere umano. Questo: «fin da subito» è abbastanza difficile da collocare. Quando il bambino comincia ad attendere? Credo sia impossibile dirlo; ma è in questo momento che egli incomincia a rappresentarsi la realtà.
L’attesa del soddisfacimento del desiderio viene riempita da ricchi giochi fantastici; nella tensione dell’attesa vengono evocati personaggi che, pur avendo qualche legame con il desiderio, arrivano, talvolta, da regioni lontane, inaspettate; proprio come a teatro. E quando il desiderio crede di potersi scaricare (perché il mondo esterno è pronto a soddisfarlo finalmente) accadono due cose bizzarre. La prima cosa bizzarra è che alla scarica del desiderio si sovrappongono tutte quelle immagini fantastiche, teatrali, che si erano prodotte nella tensione dell’attesa, e perciò la rappresentazione continua. La seconda cosa bizzarra è che il desiderio, nel momento del suo appagamento, si trova indebolito; buona parte della sua energia era stata assorbita dalla rappresentazione.
È un’esperienza comune quella in cui, dopo aver tanto atteso ed immaginato un avvenimento piacevole, esso, quando ci si presenta, ci lascia insoddisfatti, come qualcosa di ormai stanco e sbiadito.
In tutte le fantasie che immaginano una realtà è sempre presente la lotta tra i buoni e i cattivi, tra i desideri e ciò che loro si oppone. Talvolta gli eroi siamo noi stessi, talaltra sono invece nostri sostituti; ma la lotta è continua ed incessante. La cultura non è quindi lo specchio della realtà: la cultura è il nostro progetto della realtà. È il teatro del teatro.
La filosofia, l’arte della classe dominante e la cultura popolare tentano tutte di dare una visione organica e complessiva dell’uomo e del mondo. In nessuna epoca queste tre espressioni culturali hanno agito separatamente; tutte e tre unite sono «la cultura di una civiltà». Anche ogni singolo essere umano, vivendo, rappresenta, a se stesso e agli altri, la propria vita.
Ritengo che siano sempre compresenti e complementari tre istanze psichiche fondamentali: la prima è la relazione esperienziale che si costruisce attraverso la vita e che continuamente progetta e tenta di controllare; la seconda è la rappresentazione che io mi faccio di ciò che ho e di ciò che sono; la terza, che si potrebbe anche considerare un aspetto della seconda, consiste nel mimare continuamente la nostra situazione esperienziale; nell’essere contemporaneamente noi stessi e gli interpreti di noi stessi.
Non riesco a decidere se, per l’uomo, venga prima l’esperienza o l’espressione di questa; forse non è di nessuna utilità il cercare di scoprirlo. Chi muove e sente attraverso i movimenti e attraverso sensazioni, esperisce se stesso. Un se stesso, però, che non è un substrato stabile e individuabile, attorno al quale girano le sensazioni; ma è un fascio di rapporti in cui le sensazioni sono costitutive. Questo non è soltanto un modo di essere e di sentire è anche un modo di comunicare ed esprimersi. Io ho la mia esperienza che si realizza e si esprime attraverso una numerosa varietà di linguaggi. La persona si realizza attraverso i linguaggi che la costituiscono.
Alcune grossolane e semplicistiche teorizzazioni del linguaggio, verbale e non, iniziano col dividere ogni gesto umano in due grandi classi fondamentali: la prima comprende quei gesti che hanno come scopo il produrre; la seconda, quelli che hanno come scopo il comunicare ad altri emozioni e concetti. Questa, potrebbe sembrare una distinzione operativa; che serve a distinguere il materiale da chiarire in modo da potercisi orientare. Io penso, però, che non sia possibile costruire schemi ed operare distinzioni, confini, esclusivamente operativi; dietro allo schema ci sta sempre il significato dello schema.
La distinzione di cui ho parlato prima non opera soltanto come innocua divisione tra la congerie dei gesti umani, tentando di dividere ciò che è linguaggio, che esprime e comunica, da ciò che non lo è; nello stesso momento che opera una distinzione impossibile, spezza in due quella che io chiamo «espressione-esperienza »; cioè spezza in due l’uomo.
Ho detto che è impossibile distinguere i gesti che producono da quelli che esprimono e comunicano.
Ogni gesto ha sempre entrambe le caratteristiche. Prendiamo, per esempio, la serie di gesti miranti a produrre un piatto di cibo cucinato. Lì per lì, questi gesti potrebbero sembrare mossi esclusivamente dall’intenzione di produrre; i gesti del cuoco si articolano intorno ai vari ingredienti della ricetta ed ogni gesto parrebbe soltanto produrre e non esprimere: la mano impugna la frusta che, con il suo dimenarsi, fa gonfiare la chiara d’uovo… poi si taglia il lardo a dadini… poi « si aggiusta di sale e pepe, quanto basta »… e così via. « Dopo aver messo tutto nel forno ben caldo, per trenta minuti circa, si porta in tavola ».
Eppure, io penso, chi ha cucinato il cibo intendeva anche, comunicare qualcosa a coloro per i quali ha cucinato. E io credo che questo avvenga sempre in tutta la serie complessa di gesti che partono dalla prima manipolazione degli ingredienti fino al gesto che posa il piatto caldo sul tavolo. Basta stare a sentire la voce del cuoco che dice: « Spero che vi piaccia »: può significare tante cose; così pure, il gesto del commensale che avvicina la sua posata alla sua porzione di cibo non ha solo la funzione di portare il cibo alla bocca; la rapidità o la lentezza con cui il gesto avviene si trovano a comunicare qualcosa.
Questo vale per ogni gesto che compiamo: dal gesto di Napoleone che si mette da sé la corona in testa al gesto del portiere che apre il cancello.
Mentre fabbrico la mia vita e le cose della mia vita uso, contemporaneamente, quegli stessi gesti per comunicare qualche cosa.
Nessun essere umano è mai solo, neppure l’eremita nel deserto. Attorno a lui si affolla una grande quantità di personaggi che, talvolta, gli balzano addosso da lontananze dimenticate. L’eremita si inginocchia sulla sabbia; sa di essere osservato, non solo dal suo Dio. Quando diciamo che vogliamo essere soli per essere noi stessi, diciamo una gran sciocchezza; soli non siamo mai, viviamo sempre il nostro teatro. Ogni nostro gesto è compiuto come se qualcuno ci guardasse.
È molto interessante osservare una persona, sola in una stanza; non c’è bisogno di usare gli squallidi trucchi dei laboratori di psicologia sperimentale, che sono trucchi soprattutto umilianti. Basta usare i mezzi della commedia dell’arte, o della pochade fine secolo, o, meglio, basta che pensiamo a noi stessi quando siamo soli. Ognuno di noi, nella solitudine della propria stanza, ha recitato una gran quantità di personaggi. C’è chi si traveste e si guarda allo specchio; c’è chi si siede come ha visto fare in quel film.
Ma il gesto-comunicazione non riguarda soltanto i gesti macroscopicamente teatrali. Poiché nessuno di noi può mai sentirsi, in realtà, completamente solo; ogni gesto deve tenere conto di altre presenze, fantastiche o reali, non importa. Io mi sento sempre anche di fronte ad altri; altri che devo blandire, ingannare, da cui farmi perdonare, ammirare. Perciò ogni mio gesto tende a comunicare qualcosa di me e voglio, anzi esigo, che gli altri lo sappiano.
D’altra parte, anche i gesti che, esplicitamente, sembrano realizzarsi esclusivamente nella loro intenzione comunicante non realizzano, assolutamente mai, la sola comunicazione. Se io parlo a qualcuno per raccontare una mia emozione o un fatto che mi è accaduto, sempre, mentre parlo, costruisco, più o meno consciamente, la mia comunicazione, al fine di realizzare anche scopi che vanno oltre la comunicazione stessa. Questo vale per il discorso che racconta la mia vita passata, come vale per lo sguardo che voglio che esprima tristezza. Con quelle parole non voglio soltanto raccontare che « quando ero ragazzo avevo un amico che forse… ». Con il lento ruotare dei miei occhi, meglio se umidi di lacrime, non voglio soltanto dire all’altro « sono triste ». Tutti questi sono segnali che io uso, intenzionalmente, per ottenere, per produrre qualcosa.
Ogni gesto non è, dunque, soltanto il risultato di una intenzione che mira a produrre un effetto più o meno concreto, unita e sovrapposta ad un’intenzione che tende all’espressione e alla comunicazione;
ogni gesto è anche ricco di intenzioni fattive ed espressive che si sovrappongono, si intrecciano e si condensano.
Il prodotto più autonomo della esigenza di rappresentare è ciò che, comunemente, viene chiamato «cultura». La cultura ha distinto se stessa in tre grandi sottoclassi: la filosofia, la scienza e l’arte. Possiamo tenere per buona questa distinzione: tanto non cambia nulla. Rimane però il fatto che, a mio parere, la cultura è il risultato dell’istanza del «rappresentare ».
Quando un gruppo sociale riflette su’ di sé, sul proprio stare nel mondo e sulle caratteristiche di questo mondo, questo riflettere vuoI dire rappresentare, vuoI dire preparare una scena sulla quale agire, ma questo agire e questa scena costruiscono una realtà che si realizza nel momento in cui viene rappresentata.
Se le strutture psichiche di un gruppo o di un individuo non si trovassero continuamente nella tensione tra pensiero di… e rappresentazione di… noi e il nostro mondo saremmo trasparenti ed immutabili.
Se il mio vivere è anche il mio rappresentarmi, la rappresentazione cambia continuamente, forse impercettibilmente; ma cambia irt ogni istante della mia storia e, ripeto, questo vale per il singolo come per il gruppo. Una cultura, come ho detto prima, è un prodotto abbastanza autonomo e strutturato al suo interno. Gustav Mahler diceva che una sinfonia è compiuta, è organica, come un mondo; un mondo rappresentato, aggiungo io, un mondo che racconta se stesso attraverso i suoni. Quest’immagine vale anche per la cultura nel suo insieme; e la rappresentazione che viene agita è la lotta di due forze: il piacere e il dolore, che per l’essere umano si chiamano sempre bene e male.
Il piacere e il dolore sono presenti alla vita fin da subito; subito quando? Per il momento, dico: « subito» e basta. Questo « subito» esprime una data così precisa da non avere bisogno di altre specificazioni. Stavo dicendo che fin da subito nella vita sono presenti il piacere e il dolore; ma la psiche umana ha, secondo me, una costituzionale incapacità di comprendere, sul serio, il significato del piacere e il significato del dolore. Il piacere è subito sentito come bene e il dolore è subito sentito come male. Ma si potrebbe obbiettare che si può anche invertire il discorso, e dire che la psiche umana sente fin da subito il bene e il male, e che può, proprio avendo una costituzionale incapacità a capirli, sentirli come piacere e come dolore.
Pur riconoscendo che sto giocando ai limiti della metafisica, non accetto il capovolgi mento del mio discorso, perché sarebbe più metafisica ancora; io ritengo che la metafisica, sia ineliminabile; e debba essere affrontata come un male necessario.
Io dichiaro esplicitamente di non essere un metafisica, e questa dichiarazione mi valga come difesa. Dicevo quindi che non accetto il capovolgi mento del discorso: io affermo che il piacere e il dolore sono nella vita fin da subito; ma non sono e non costituiscono la vita.
Vorrei puntare i piedi ben saldi su questo « subito» e cercare di spingermi, con sforzo, un po’ più indietro, in un prima un po’ prima di questo « subito ».
Ho detto che la vita ha il piacere e il dolore; questo lo so, perché anch’io vivo e me li sento addosso fin da sempre, o meglio, fin da « subito» però ho anche detto che non sono la vita. La vita non è altro che un oscuro o chiaro desiderio – desiderio di piacere – quindi la vita è piacere; perché si dirige soltanto attraverso il piacere.
Alcuni vecchi saggi mi urlano di lontano che il desiderio, per il fatto stesso che è desiderio, è mancanza; se è mancanza di piacere, non può essere il piacere, perché il piacere è assente. lo, contro la saggezza degli antichi logici, affermo che il desiderio del piacere e il piacere sono i due elementi costitutivi della vita.
Piacere del desiderio e desiderio del piacere agiscono in un’unica situazione, nel gesto iniziale, nel gesto costitutivo. Ma un aspetto ancora manca alla costituzione del vivente: il suo costituirsi come piacere-desiderio che si costruisce e si realizza, sempre, in una situazione relazionale. Ora mi chiedo: ho ecceduto nel delirio metafisica, oppure nella metafisica delirante?
Ho detto che l’essere umano è costituito dal desiderio del piacere e dal piacere del desiderio ed ho aggiunto che l’uomo è costituito dal suo dirigersi verso l’altro. Il dispiacere, il dolore, l’altro attore della rappresentazione, dove si situa, quando sorge?
Sorge fin da subito; ma non contemporaneamente. Quando l’essere vivo sente il proprio desiderio, percependolo come piacere, nello stesso istante si struttura, dirigendosi verso: bisogno, piacere, desiderio esistono come direzioni, sono una direzione; ma, in questo dirigersi, accade, io credo sempre (ma nello stesso tempo affermo: non necessariamente), che il desiderio venga contraddetto, il piacere inibito, il bisogno negato.
La frustrazione si presenta con immediatezza all’essere che vive, il quale se la sente pesare addosso e da cui deve in qualche modo difendersi.
La nostra cultura ha inventato un mito: Narciso, il figlio di Cefiso e Liriope, innamorato di se stesso, contempla la propria immagine riflessa nell’acqua, la vuole baciare e in questo gesto trova la propria morte, annegato.
La morte di Narciso esprime l’impossibilità reale di una vita tutta ripiegata su se stessa. Narciso muore perché non può vivere. Ci può essere molto di moralistico in questa storia che pare adombrare discorsi del tipo: chi vive solo per sé è sterile; oppure: è giusto che muoia chi non ama che se stesso, e così via. lo preferisco interpretare il mito come mi fa comodo e come più mi piace, giungendo anche a raccontarmelo un po’ diverso, per esprimere a mo’ di parabola un altro mio pensiero: « Narciso, innamorato respinto, cerca di consolarsi corteggiando la propria immagine ».
Narciso è, per me, la rappresentazione di due pensieri. Con il primo pensiero, voglio affermare che la chiusura totale verso l’altro e l’assoluto ripiegamento su se stessi sono impossibili. Non voglio dire che sono moralmente condannabili, non voglio neanche dire che, poiché è impossibile realizzarli fino in fondo, una certa apertura, quindi, verso l’esterno rimane pur sempre. Quello che voglio intendere è che, se l’apertura e la relazione sono costitutive dell’essere umano, i loro contrari lo negano prima ancora che egli si ponga. Attraverso il secondo pensiero, io affermo che il gesto di Narciso è un gesto essenzialmente difensivo: Narciso cerca di sfuggire il dolore negandone l’origine. Narciso chiede a se stesso di appagare il suo desiderio.
Quattro sono le cause di quell’atteggiamento di chiusura che ormai siamo avvezzi a chiamare Narcisismo: 1) la frustrazione; 2) la compensazione; 3) la paura; 4) la difesa. Ne tratteremo ponendole in successione: prima l’una, poi l’altra e così via; ma, in realtà, queste cause si dispongono circolarmente e si rafforzano reciprocamente.
La frustrazione del desiderio è il « secondo-primo» sentimento che l’uomo’ prova (dico: «secondo-primo» perché, pur manifestandosi fin da subito. è uno stato che «consegue a…»): il desiderio del piacere e il piacere del desiderio. nel loro dirigersi verso…, trovano una barriera, un’ottusità, una sordità, cioè una impossibilità. L’essere vivente, che è costituito da questo dirigersi verso…, vive una situazione di sofferenza e disorientamento; ma, nuovamente, il desiderio del piacere e il piacere del desiderio risorgono e l’essere vivente cerca una compensazione: se l’altro da me mi respinge – dice a se stesso l’ individuo io mi appago in me stesso », e la fantasia dilata il «me» smisuratamente.
Come ho già detto, sorgono tensioni successive. È presente. però, la paura continua di ulteriori rifiuti e frustrazioni. Il desiderio del piacere e il piacere del desiderio tentano ancora di dirigersi verso…, tenteranno sempre. Se però il dolore irrompe, con la sua forza di rifiuto, massicciamente e frequentemente nell’esperienza del vivente, costui instaura come meccanismo di difesa, il ripiegamento; tentando di rifiutarsi di percepire il fuori di sé. Ma, abbiamo detto, il vivente è costituito dalla relazione e dal dirigersi verso…. per cui, non potendo abolire questo meccanismo. tenta allora di porsi in relazione con sé, dirigendosi verso di sé. Questo è il primo meccanismo di difesa, forse l’unico. Il narcisismo è una situazione esperienziale che l’essere umano impara ad usare come difesa. La situazione: «da subito» consiste nel desiderio del piacere e nel piacere del desiderio.
Vogliamo chiamare questa situazione «narcisismo primario»? Altrove, io ho usato questa espressione per descrivere questa situazione. Ora non sono più dello stesso avviso; adesso ritengo che sia meglio chiamare situazione narcisistica l’originario atteggiamento di difesa dal dolore, che viene attuato negando il fuori di noi che ci ha respinto; con una negazione che è anche un gesto morale di condanna.
Ho detto che il narcisismo è un atteggiamento difensivo. Vi sono strutture di personalità nelle quali la difesa narcisistica è preponderante, in nessuno. comunque, è completamente eliminabile, poiché, al momento. sono ineliminabili frustrazione, compensazione e paura della frustrazione.
Anche le caratteristiche del narcisismo sono quattro: 1) paura; 2) violenza; 3) antropofagia; 4) labilità dell’investimento libidico. Ecco che ritorna il termine paura. Avevo posto la paura tra le cause della difesa narcisistica, ora la ripropongo, come prima, nell’elenco delle caratteristiche essenziali del narcisismo.
Abbiamo detto che il piacere è alle origini ed è costitutivo dell’individuo, dobbiamo anche dire, però, che la possibilità della distruzione del piacere sorge contemporaneamente al suo stesso sorgere.
La precarietà è un elemento costante del modo d’essere del vivente: l’individuo impara subito come il desiderio, presente sempre, possa sempre essere distrutto. La paura esprime l’atteggiamento tipico di chi teme di perdere ciò a cui tiene massimamente. Il timore e la paura però non rimangono a lungo nell’essere umano senza provocare i loro effetti. Chi teme, chi ha paura, si irrigidisce; acquista in un primo tempo l’atteggiamento di diffidenza poi scopre (per meglio dire: «impara») la violenza.
Il narcisista, o colui che vive un momento narcisistico, è inevitabilmente violento. Si tratta però di una violenza tutta particolare: una violenza inconsapevole. Chi è prigioniero della difesa narcisistica ha negato l’altro; e il modo migliore di negare l’altro è quello di rifiutarsi di percepirlo, rifiutandosi anche di ascoltarlo. Il narcisista non ascolta; egli parla, non sa neppure a chi stia parlando, o meglio, non si pone il problema di essere o no in sin toni a con l’altro; per il narcisista l’altro non ha una realtà che si dirige verso… Chi è chiuso nella difesa narcisistica ascolta soltanto se stesso e violenta l’altro, costringendolo ad essere ciò che egli vuole che l’altro sia.
Ecco perché ho detto che il narcisista è antropofago: perché non permette agli altri di vivere autonomamente; rifiuta loro ogni autonomia esistenziale, perché se fossero autonomi potrebbero aggredirlo. e ferirlo. L’altro viene quindi ingoiato, inglobato nel mondo del narcisista.
Quali siano i sentimenti dell’altro, marionetta nelle mani del narcisista, non importa più; peggio: il narcisista non si pone neppure il problema. Questa incapacità di percepire l’altro ha la sua origine in un rifiuto d’amore: chi mette in atto difese narcisistiche non può cedere la propria immagine ad un altro e a fatica ne sente il richiamo libidico. Potremmo dire che il narcisista « scopa »; ma non fa mai «l’amore ». Questa espressione idiomatica: « scopare », esprime abbastanza bene il complesso stereotipo di gesti compiuti da un narcisista nel rapporto sessuale. Nel rapporto narcisistico, il piacere sessuale cerca essenzialmente gratificazioni sul sé, l’altro è un pretesto, uno specchio che riflette l’immagine del narcisista.
Spesso il narcisista è profondamente convinto di essere «perdutamente innamorato »; ma non appena l’oggetto amato cerca di ribellarsi al ruolo impostogli, di pura ombra senza desideri, ecco che il sentimento così assoluto sfuma. Il narcisista non tollera di avere rapporto con un essere umano che manifesti esigenze, affettive o sessuali, diverse dalle proprie. Quando è costretto a percepire l’altro come altro da sé: il narcisista si sente offeso, perche ne ha paura; e allora l’innamoramento cade con estrema facilità e un nuovo oggetto verrà investito libidicamente, ancora una volta l’innamoramento parrà dapprima emotivamente intenso; ma un’altra volta cadrà, non appena l’altro cercherà di farsi percepire, e tutto ricomincerà da capo.
Avrei voluto descrivere sia le cause della difesa narcisistica, sia le caratteristiche del comportamento narcisistico con asettica neutralità morale; questo – mi hanno detto – è l’atteggiamento del buon scienziato. Mi accorgo di non esserci riuscito: giudizi morali o moralistici permeano le descrizioni che ho fatto sopra; ma non mi va di riprendere tutto da capo e di riesporlo in altro modo. Per fortuna, mi accorgo che mi sono servito di due tipi di giudizio morale non solo contrastanti; ma addirittura opposti fra loro. In un primo tempo, ho detto che la difesa narcisistica sorge in una situazione di precarietà: chi si sente rifiutato nel proprio dirigersi verso l’altro, cerca in qualche modo di superare la frustrazione, negando l’altro e cercando gratificazioni sul sé, e così facendo ho proposto il narcisista come una vittima. In un secondo tempo, ho proseguito il discorso, descrivendo in modo truculento la perfidia del narcisista, trasformandolo così in carnefice.
Per ora lascio aperto il discorso…
L’atteggiamento narcisistico compromette la persona nella sua intierezza; non solo il rapporto sessuale, ma ogni altro tipo di rapporto acquistano un significato particolare. Chi vive narcisisticamente non percepisce i mutamenti di umore di chi gli sta intorno e non percepisce neppure i cambiamenti ambientali. Ricordo un mio paziente molto narcisista il quale continuò a frequentare il mio studio durante un periodo in cui mobili e suppellettili venivano cambiati; egli non si accorse assolutamente di nulla. Quando gli feci notare i cambiamenti rimase stupefatto e anche un po’ offeso. Da quel giorno incominciò, a scadenze regolari, a notare che un mobile era stato spostato, un altro sostituto, che un nuovo oggetto era comparso; naturalmente sbagliando quasi sempre. Una signora dolce ed elegante, convinta di essere molto sensibile, altruista e attentissima ai sentimenti degli altri, dopo aver sentito un mio discorso in pubblico sulla impermeabilità dei narcisisti nei confronti del mondo esterno, rimase alquanto toccata e, da quella volta, quando mi incontra, scrutandomi con attenta amorevolezza, mi attribuisce le situazioni emozionai i più strane e variopinte; palesemente, continua a non percepire niente di me, a non vedermi neppure.
La posi tura narcisistica è, secondo me, l’impedimento maggiore per quelli che vogliono diventare psicoterapeuti. La teoria psicoanalitica classica afferma che la chiusura narcisistica, nel paziente, impedendo l’instaurarsi di un transfert produttivo, rende impossibile l’analisi. Ciò è vero; io ritengo, però, che l’atteggiamento narcisistico sia ancor più pericoloso per chi si assume l’onere di fare il terapeuta. Conosco alcuni terapeuti profondamente chiusi entro le loro difese narcisistiche i quali mi mano l’interesse durante le sedute. Il massimo coinvolgimento affettivo e politico che riescono ad avere con il cosiddetto paziente consiste in un continuo contrappunto, caratterizzato da un continuo, e mentale, «anch’io »… «io invece ».
Qualunque cosa il paziente dica loro il massimo sforzo che riescono a fare consiste nel confrontare continuamente loro stessi con i sentimenti e le scelte dell’altro. Anche il modo di dialogare del narcisista è tipico: o non ascolta, e attende con impazienza che l’interlocutore smetta per cominciare a parlare e gli stesso, oppure replica sempre iniziando con la formula: «io invece… ».
Quando assumiamo l’atteggiamento narcisistico, non riusciamo a calarci libidicamente nell’altro: la carne, il calore, la sessualità dell’altro ci rimangono esterni; guardiamo gli altri senza vederli, parliamo senza ascoltarli, li tocchiamo senza sentirli.
La difesa narcisistica è anche la maggior responsabile dell’ottusità mentale e, talvolta, anche dell’incapacità di memorizzare e di apprendere. Per imparare davvero qualcosa è indispensabile percepire sensualmente tutto ciò che accade intorno a noi. È indispensabile essere all’erta e sentire le somiglianze e le diversità. Studiare quando si è in una situazione di narcisismo significa scontrarsi con la difficoltà a non ricordare ciò che si legge e dover ricominciare ogni volta che si è al termine di una pagina, oppure riuscire a imparare alcune nozioni senza sapere poi quale uso farne, perché si è incapaci di proiettarle sul reale.
Un giovane psicoanalista, ottusamente narcisista, mi poneva, con simpatica umiltà, questo problema: « Io – mi diceva – dopo alcuni anni di analisi personale, dopo aver letto la maggior parte dei testi della letteratura psicoanalitica e psichiatrica, ufficiale e non, quando mi trovo davanti ad una persona e voglio cercare di capirla, ho l’impressione che tutto quello che ho studiato sparisca, o meglio: non lo so applicare; la persona parla e a me viene sonno ». Questa, io credo è una esperienza comune a molti psicoterapeuti alle prime armi. Il rapporto diretto con la psiche di un’altra persona li sconvolge e li disorienta. Però, chi ha condotto la propria analisi senza coinvolgimento reale col terapeuta, cercando soprattutto di parlare e ascoltando poco, se pure è riuscito a chiarire a se stesso molti problemi psichici, non è però riuscito a spezzare il diaframma che è indispensabile spezzare perché una analisi possa dirsi riuscita. È il diaframma costruito dalla paura e dalla difesa narcisistiche. Questa pellicola, talvolta sottile, impalpabile; ma paralizzante come un’armatura, tende continuamente a riformarsi, soprattutto dopo esperienze frustranti.