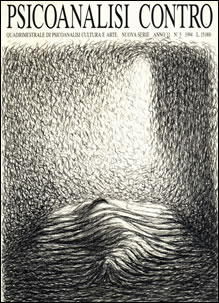Voglio cantare il molle Eros pieno di ghirlande ricche di fiori
Eros che domina gli uomini, signore degli dèi (Anacreonte, fr.28, trad. S. Quasimodo)
1. Con questa citazione si chiudeva la riflessione del mese scorso. Gli antichi Elleni vedevano in Eros il dio il cui potere tutti soggioga: gli esseri mortali e gli immortali, nell’anima e nel corpo. Ancora oggi si identifica in lui l’amore. Forse solo il cristianesimo ha saputo riproporre con altrettanta forza un concetto divino di amore che coinvolge l’anima e il corpo. Il Verbo si è fatto carne e la materia è diventata segno manifesto dello spirito: bisogna rispettare ciò che è fatto di materia per non disprezzare la divinità da cui emana. La realtà è espressione di un assoluto, trascendente o immanente che lo si voglia considerare.
Anche allora, però, Eros, come oggi l’Amore, faceva paura. Il Poeta lo definisce “molle”: abròs, aggettivo che ha una connotazione di debole effeminatezza. Perché dunque il giovane Eros è molle? Forse il fatto è che anche gli antichi percepivano che nell’amore c’è qualcosa che rende snervati e deboli e questi sentimenti proiettavano sul dio, per esorcizzare in parte la sua forza e renderlo meno terribile.
L’arte ha parlato sempre ed ancora parla dell’espressione sessuale dell’amore riconoscendole un forza incontenibile: dall’amore sublime di Dante per Beatrice e di Werther e Carlotta, all’amore carnale, la passione che porta al delirio, alla follia, alla distruzione che unisce in modo inscindibile la coppia: amore-morte. Dal romanticismo in poi si è avuta una tale paura di Eros da volerlo trasformare in un antropofago: un maschio stupratore o una femmina divoratrice.
E’ vero che il desiderio sessuale diventa spesso incontrollabile, ma non c’è davvero Eros in queste odierne forme pseudoartistiche che sono invece pornografia o istigazione alla mercificazione del consumismo• siano la storia dell’Angelo azzurro, i manifesti di Toscani oppure gli spot televisivi. Eppure anche in questo secolo corrotto e perverso viene usata l’espressione: “Non facevamo nulla di male”, per dire che non si stava facendo nulla di sessuale: ancora nell’inconscio sociale dell’occidente e forse del mondo, il sesso è “male”, perché impuro in sé, al di là e prima di ogni giudizio morale sulle forme di sessualità considerate lecite o illecite.
L’amore va oltre la sublimazione dei ben pensanti e la consapevolezza delle intenzioni degli artisti: né gli uni né gli altri sanno tradurre pienamente la ricchezza di un sentimento che coinvolge l’anima e il corpo. Forse solo la musica vi si avvicina proprio perché non ha bisogno di essere mediata dalla parola e non è costretta all’esplicitezza del segno, ma può alludere ad entrambi e superarli al contempo: un accordo di settima diminuita può provocare un’intensa emozione sessuale, un intervallo di ottava o cinque suoni in sequenza possono turbare più di qualsiasi figura o parola.
2. La scienza è il campo che viene ritenuto quello dell’oggettività per antonomasia e due sono le figure più diffuse e conosciute: una è quella del divulgatore scientifico, empirico ed inconsapevole, pago della sua pretesa oggettività e delle certezze raggiunte una volta per sempre; l’altra è quella dello scienziato positivista che non arriva a porsi domande sull’origine dei dati e sulle finalità dei programmi, convinto che il significato della scienza sia fine a se stesso. Molto meno conosciuta perché poco diffusa è quella del ricercatore capace di dubitare, profondo conoscitore della articolata complessità della scienza e che per questo ne applica con onestà i metodi, senza pretendere di affermare verità assolute.
Credere di sapere cosa è vero e cosa è falso, il dogmatismo scientifico, il non voler porsi il problema di che cosa sia giusto e cosa sia ingiusto per la scienza, ha causato all’umanità catastrofi. Gli scienziati che hanno capacità critiche ed autocritiche, sono consapevoli della problematicità di ogni snodo scientifico, della relatività di ogni verità e scoperta; impegnati in un lavoro che si scontra ogni giorno con mille contraddizioni, sereni di fronte alle prospettive della metafisica di cui sentono il peso, ma da cui non cercano di scappare eludendola con giochi mentali sul pensiero debole o sul pensiero forte. Questi sono gli scienziati-filosofi che spesso hanno gettato l’allarme di fronte alla prospettiva dei pericoli che l’errata interpretazione della funzione dello scienziato può causare all’umanità.
Anche nei confronti della sessualità c’è stata una molteplicità di atteggiamenti scientifici: chi l’ha fatta coincidere con il meccanismo procreativo; altri l’hanno considerata soltanto un istinto teso a soddisfare una pulsione scaricandola.
Un settore importante della psicoanalisi ha voluto identificarla con il principio di piacere in generale, rifiutando distinzioni tra sessualità e piacere e attribuendo all’uomo la caratteristica di oscillare esclusivamente tra i due poli opposti del piacere e del dolore. Le pulsioni dell’essere umano non si limitano invece a questa oscillazione tra due soli principi, ma sono polidirezionali, allo stesso tempo autocentriche ed eterocentriche.
3. Un tentativo può essere fatto di ricostruire lo sviluppo della sessualità dell’essere umano nel corso della sua storia, sapendo di partire da un punto di inizio più o meno arbitrario, ma che comunque può costituire -per il momento- il fondamento del discorso. Il principio del piacere che da sempre muove l’essere umano non va inteso come una forma di egoismo, concentrato interamente sulla propria persona; ma come una pulsione che mira a realizzare il rapporto di dare ed avere con l’altro (e non semplicemente a scaricarsi sull’oggetto). Questo vale per le poche cellule che costituiscono il primo embrione, per il feto che attraverso il rapporto con la madre entra in relazione anche con il mondo ed infine per la persona adulta. La cellula, l’embrione e il feto sono in rapporto con il mondo e vanno alla ricerca dell’altro: è un meccanismo istintuale e programmato. L’individuo alle sue origini e anche dopo la nascita ha bisogno dell’altro per sopravvivere, non solo perché dall’altro riceve calore e nutrimento, ma anche perché l’altro è condizione indispensabile per il ritrovamento di se stessi, perché è un elemento ineludibile della costruzione della psiche individuale. Una macchia bianca su di un foglio bianco non è percepita da nessuno e non percepisce neppure se stessa; un corpo che non s’incontrasse con le parti di se stesso e con un mondo circostante sarebbe un’entità dispersa, indecifrabile ed indescrivibile.
Il piacere del contatto, la scoperta del corpo dell’altro in rapporto col proprio, che è anche un piacere d’amore, che è già sessualità nel momento della sua fondazione biopsichica, struttura l’essere umano fin dalle sue origini. Ciò significa che il piacere originario non è masturbazione, non è omosessualità, non è eterosessualità: il bambino, dentro e fuori del ventre materno ricerca l’altro in cui trovare il soddisfacimento del piacere che è pulsione di vita. Non si tratta delle pulsioni parziali, non si tratta di sfregamento di organi in cerca di una scarica, ma siamo in presenza di un’espressione di amore che si rivolge all’altro per trovare la sua piena realizzazione, affettiva e biologica. Il contatto fisico, con il piacere che implica, rappresenta il soddisfacimento immediato di questo bisogno di amore; per garantirsi il successo, il corpo del neonato inventa e ricerca i modi della seduzione dell’altro. Questa è una realtà che l’uomo adulto fatica a comprendere perché il bambino e il feto non riescono a comunicargliela con un linguaggio a lui adeguato. Per questo la lettura che gli scienziati e i filosofi fanno del principio di piacere e della sessualità non rende giustizia alla complessità della pulsione sessuale e amorosa originaria; ma si limita a parcellizzarla, ad adeguarla ad una concezione seconda di sessualità, condizionata già dagli esiti che essa ha avuto, dopo aver messo in atto le difese alle quali è stata costretta a fare ricorso, incontrando il mondo.
4. Questa modalità di lettura, parcellizzata, deve essere riveduta, anche se è vero che l’osservazione scientifica necessariamente ritrova nello sviluppo della sessualità umana alcuni passaggi obbligati.
La masturbazione con toccamento dei genitali accompagnato da scariche di piacere intenso è molto precoce nell’essere umano e inizia prima della maturazione sessuale sia del maschio sia della femmina. La si considera soprattutto una pratica maschile, dal momento che, per ragioni culturali e fisiologiche, si registra una maggior attenzione del maschio per i propri organi genitali esterni, mentre la femmina li scopre dopo e con più difficoltà; ma non esiste una differenza sostanziale, anche se non si può dire che sia un fenomeno assolutamente analogo nei due sessi, per tempi, modalità e intensità. La cultura condiziona per entrambi i sessi questa pratica, frapponendosi tra l’individuo e la natura, per cui nelle femmine il coinvolgimento del corpo è più complessivo e significativo, mentre nei maschi il piacere si concentra sull’organo sessuale; forse sarebbe auspicabile un riequilibrio che facesse riappropriare gli uni della totalità del proprio corpo e le altre della specificità degli organi sessuali. In ogni caso il fenomeno – sia pure con differenti connotazioni, significati e risonanze – accompagna tutto l’arco della vita umana e non si limita alla fase prepuberale o adolescenziale.
Di fatto, ci sono infiniti modi che ripropongono a chi non ne abbia timore il piacere del contatto con il proprio corpo e di questo con il calore del sole, il fresco dell’aria, la dolcezza delle acque, la morbidezza di un tessuto, la vitalità palpitante di una mano che accarezza. Sono i cinque sensi che – quando non si cade prigionieri della gabbia solipsistica che esclude il fuori di sé – vengono coinvolti in un’espressione di sessualità che non è più autistica, ma che si proietta nuovamente all’esterno. La masturbazione non è fase preliminare, segno di immatura inferiorità nei confronti della sessualità vera e propria, ma è invece segno di salute psichica, quando significa riappropriazione del proprio corpo e non quando è sintomo di una sessualità malata che teme o allontana da sé l’altro.
“Nessun uomo è un’isola”
diceva già John Donne.