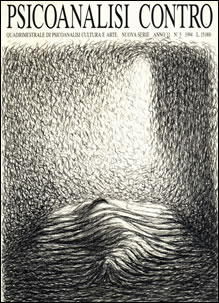Uno degli elementi fondamentali della teorizzazione dell’Edipo e dei suoi successivi sviluppi è quello riguardante il ruolo che questo complesso svolge all’interno della psicodinamica femminile. La bambina deve capovolgere ad un certo punto, per altro molto precoce, la direzione verso la quale indirizzare l’oggetto d’amore: mentre il bambino continuerà ad avere per oggetto affettivo e sessuale la madre ed il suo corpo, la bambina invece dovrà staccarsi dall’intimo rapporto con la madre fino a capovolgerlo in odio perché la sentirà rivale ed in opposizione alla realizzazione del proprio obiettivo, quando, identificandosi con essa, rivolgerà al padre il proprio desiderio sessuale. Tutto questo almeno in una società e una cultura che impone al maschio adulto di scegliere come oggetto sessuale la femmina e viceversa. Freud ha spiegato come questa necessità sia universale facendo ricorso alla fantasia dell’orda primitiva, riferita in “Totem e tabù”, (1912/13), anche se molti antropologi hanno messo in dubbio questa teoria, centrata eccessivamente sul maschio e basata su una presunta realtà preistorica di cui non si reperisce traccia. Molti psicoanalisti e psicoanaliste hanno però accettato la struttura triadica come fondamento del complesso di Edipo, scordando forse che almeno all’inizio il rapporto è soltanto diadico: infatti sia il maschio sia la femmina hanno rapporto esclusivamente con la madre. Per questo ritengo fondamentale approfondire le ricerche sul rapporto madre- feto durante la gestazione.
Per illustrare le ragioni delle mie scelte teoriche vorrei anch’io fare ricorso al mito e alla tragedia dell’antica Ellade.
La tragedia dell’Edipo Re (che qui sintetizzerò in modo forse eccessivo) prende l’avvio a Tebe dove al re Laio e alla moglie Giocasta l’oracolo aveva predetto che il figlio della loro unione avrebbe un giorno ucciso il padre e sposato la madre. Per scongiurare gli esiti della predizione il re, subito dopo l’infausta nascita, diede ad un pastore l’incarico di uccidere il piccolo Edipo. Il pastore mosso a compassione del bambino lo allevò lontano dalla città, fra i monti. Il giovane Edipo però, ormai fatto uomo, volle andare alla ricerca del padre e della madre. Sulla via verso Tebe incontrò un nobile arrogante che gli negò il passo e nella lite che seguì lo uccise. Quell’uomo era Laio. Giunto a Tebe fu in grado di risolvere l’enigma della Sfinge, liberando la città dalla sua tirannia. In premio ottenne la mano della regina, da poco vedova di Laio. Gli dei, indignati per il delitto e l’incesto, punirono Tebe con una pestilenza e solo l’indovino Tiresia ebbe il coraggio di rivelare l’orribile verità. Giocasta s’impiccò ed Edipo si accecò con le proprie mani. Qui si chiude la prima tragedia della trilogia.
Nell’Edipo a Colono, il vecchio Edipo, guidato dalle figlie Antigone e Ismene, è in marcia verso Colono, villaggio non lontano da Atene, su cui regna Teseo.
Egli intende aspettare la morte nel bosco delle Eumenidi. Prima di addentrarsi nella foresta il vecchio cieco prega le figlie di lavarlo e si fa accompagnare da Teseo fino ad un punto, dove ode la voce di Zeus che lo chiama a sé: rispondendo al richiamo si inoltra da solo tra gli alberi e scompare. Nessuno, nemmeno Teseo, riesce a ritrovare il suo corpo e l’ultima scena vede il re di Atene e le due figlie di Edipo in preghiera davanti al prodigio. La bellezza di questa storia, anche per come è narrata, resta intatta ancora oggi. Per questo e per i suoi significati, l’ho scelta come introduzione al mio discorso sull’Edipo. A Colono si realizza un rapporto diadico che è tra il figlio-Edipo e il padre-Zeus. Purtroppo oggi la figura del padre è ancora da costruire per cui il rapporto diadico si gioca tutto tra il figlio e la madre, soprattutto nel periodo gestazionale.
Nel ventre materno il bambino è mosso dalla voglia di vivere, ma fin da subito questo desiderio si connota di coloriti affettivi: il feto, come prima di lui l’embrione e poi il bambino, hanno bisogno di dare e ricevere amore. Cosa è questo amore? Anche se è impossibile definirlo, anche perché troppe definizioni ne hanno dato la cultura e l’arte, la sua è una presenza che alimenta da sola la vita dell’essere umano. La perfezione sarebbe che ogni concepimento fosse frutto d’amore e la storia successiva uno scambio continuo d’amore tra l’individuo e gli altri, prima di tutti il padre e la madre. Il piacere sessuale non è, di per sé, segno d’amore e pochi purtroppo sono i figli che nascono per il fatto che i genitori vedono in loro la realizzazione di un progetto affettivo che non riguardi solo le proprie persone, ma il frutto di quel concepimento. Il piacere del sesso e l’amore della coppia non sono sufficienti a garantire al figlio l’amore a cui ha diritto per sé. Paradossalmente si potrebbe auspicare che la procreazione diventi un giorno un fatto scisso dalla sessualità e che l’amore della coppia per il bambino tenda a realizzare il progetto esistenziale di quest’ultimo e non di uno o di entrambi i partner.
C’è purtroppo anche una fasulla letteratura che celebra l’indissolubilità di Eros e Thanatos, amore e morte, ma questa è una falsità: l’ amore è sempre vita vissuta per la vita dell’altro. L’amore può essere il legame che unisce più di due o tre persone, senza che nessuno si senta proprietario o proprietà dell’altro. Non è quindi l’amore per il figlio che giustifica frasi come: “Tu sei mio, sangue del mio sangue, carne della mia carne”. Il padre o la madre che le pronunciano sono malati ed ingiusti, anche quando lo sentono vivo palpitare nel grembo.