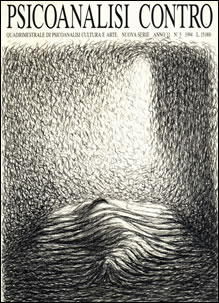La gestazione è dunque il momento del rapporto diadico tra il figlio o la figlia e la madre. Il rapporto diadico col padre, come ho detto, deve ancora venire, perché il padre ancora non esiste, forse esisterà un giorno, come dice Bloch a proposito di Dio, il quale sarà solo alla fine dei tempi, contrariamente all’opinione di chi crede che invece sia stato fin dall’inizio.
In ogni caso però la vita nell’utero della madre è permeata continuamente di influenze dell’ambiente esterno e quasi mai la vita del feto assomiglia al beato galleggiamento sommerso in un mare di beatitudine. Tanto drammatica è la vita della gestante, altrettanto lo diventa quella del feto, e questo vale anche per le emozioni che non raggiungono la coscienza della donna.
La psicoanalisi può, grazie al suo metodo di indagine, aiutare la donna a diventare consapevole delle proprie dinamiche psichiche e riesce anche in seguito a ritrovare nella vita del bambino le tracce di queste esperienze della vita intrauterina.
Ricordo una paziente che percepiva la propria condizione di gestante drammaticamente, sentendosi lacerata dal fatto di non essere più una, compatta, ma come scissa e dispersa nel gioco delle proiezioni ed identificazioni tra lei e la nuova vita che ospitava in sé. La percezione consapevole e distinta della realtà di quella nuova vita le faceva paura. “Non avrei mai voluto sentirlo, non volevo sapere che era lì, non sopporto di sentirlo muovere e anche opporsi, qualche volta, a me”. Questa drammaticità si riscontra di frequente nella gestazione: mette ansia acquisire la consapevolezza dell’autonomia esistenziale dell’individuo che si muove nel proprio ventre. Mette ugualmente ansia il suo silenzio: ci sono donne che attraversano crisi d’angoscia quando hanno l’impressione di non percepire più la presenza del bambino: “Non lo sento più, è morto”. L’embrione, fin dal concepimento, per contro cerca la propria autonomia.
Certo, questa autonomia non la raggiungerà neppure dopo la nascita, ma ciò nonostante il processo di autoindividuazione è continuo e l’ignorarne le dinamiche più precoci, durante la gestazione, può impedire di comprendere scelte e scacchi della vita successiva. Forse proprio qui si annidano le radici di una malattia gravissima come l’autismo infantile. Ci sono situazioni in cui la donna si difende e si comporta ostentando una grande calma e soddisfazione per il nuovo stato: questo tipo di gestante ha l’aria proterva, soddisfatta, come il serpente che ha appena mangiato il porcellino.
Non sempre però è così: nel suo volume “Sex, abortion and unmarried women”, Paul Sachdev sostiene una tesi molto curiosa, che però un poco surroga quanto sono venuto dicendo sulla gravidanza. L’autore sostiene infatti che per la donna è molto più faticoso portare a termine la gestazione fino al momento del parto, che non liberarsene prima con un aborto. Ci sono in effetti donne che affermano con apparente tranquillità di aver abortito anche quattro o cinque volte. Molta letteratura ed un diffuso senso comune vagheggiano che l’aborto non rappresenti dopo tutto un trauma per la donna. Sono tesi sostenute principalmente dagli abortisti e si basano per lo più sulla decodificazione di questionari impostati con notevole superficialità.
Un giorno arrivò nel mio studio una giovane donna, per chiedere un’analisi. Al primo incontro si rivelò una grave forma di depressione, con stato di ansia e fantasie di suicidio. La depressione è spesso una forma reattiva alla paura di morire alla quale si risponde abbandonandosi al gusto della morte stessa. Dopo avermi descritto abbastanza in dettaglio la propria situazione famigliare, arrivò a parlarmi di un aborto risalente più o meno all’inizio della depressione. “All’uscita dell’ospedale, dopo aver abortito mi ero sentita felice, libera da un peso. La vita con mio marito era ripresa benissimo. Poi d’improvviso sono cominciati i sintomi. Tutto questo non può aver niente a che fare con l’aborto, di sicuro. L’aborto è una pratica legale nel nostro Paese, come in mezzo mondo. Se la legge lo consente non c’è motivo di preoccuparsi, la mia depressione non può aver a che fare con l’aborto. Vero dottore?” Io tacevo e riflettevo: se quella donna avesse compilato uno dei questionari tanto diffusi nei Paesi del nord europeo, ad una domanda in proposito avrebbe certamente risposto che l’aborto non era stato per lei un’esperienza traumatica. Eppure avevo davanti a me una donna distrutta da un sindrome post-abortiva, come mi confermò il proseguimento dell’analisi. I questionari sono troppo schematici per riflettere realtà complesse come quelle della psiche. Non si può stabilire in anticipo: “Se risponde sì è ansioso; se risponde no è depresso, se dice non lo so è alcolista”. Spesso la pratica dei questionari e le relative elaborazioni statistiche sono vere e proprie truffe pseudo-scientifiche. Personalmente, quando sono costretto a farvi ricorso, elaboro personalmente griglie di lettura molto aperte e articolate e poi cerco ancora notizie supplementari sulle condizioni in cui sono stati proposti e sulle persone che vi hanno risposto.
È vero che l’esperienza della gravidanza è psichicamente traumatizzante, ma lo è altrettanto l’esperienza di morte dell’aborto. Un interessante libro di una psicoanalista junghiana, Eva Pattis, “Aborto, perdita e rinnovamento” sostiene che nella nostra società l’aborto ha il significato di un rito di passaggio (ricorrendo anch’essa al già citato termine, entrato nell’uso scientifico, preso da Van Gennep, antropologo dei primi del secolo). Il rito di passaggio è una pratica che, come abbiamo visto, sembra molto evidente nei popoli cosiddetti primitivi, ma che in realtà ha profonde radici anche nella civiltà occidentale.
La Pattis sostiene che l’aborto è una pratica universalmente diffusa, perché la donna per diventare davvero “donna” deve liberarsi dall’obbligo della maternità, uccidendo. Per la Pattis ciò è inevitabile, proprio come fu inevitabile che Edipo uccidesse il padre e sposasse la madre. Personalmente mi rifiuto di credere che sia vero che la donna ha la necessità di uccidere per sentirsi pienamente integrata nel proprio ruolo e se fossi una donna credo che mi batterei per liberarmi da una simile condanna.
Certo anche i sacrifici umani a suo tempo erano ineluttabili componenti dei riti di passaggio: Stravinsky ce ne ha dato una meravigliosa versione poetica con “Le sacre du printemps”, ma oggi nessun popolo accetta più che il passaggio dalla vecchia alla nuova stagione sia segnato da un omicidio rituale. Sulla stessa linea possiamo porre altre pratiche offensive della dignità e della vita dell’uomo, come la “mensura” ovvero lo sfregio rituale degli studenti tedeschi, o lo stupro delle associazioni giovanile naziste, di cui sono eredi i moderni naziskin, e via dicendo. Più sottilmente insidiose sono certe pratiche apparentemente “bonarie”, come l’inziazione alla galera dei giovani malavitosi romani di fine secolo: bisognava aver passato la “porta” per essere davvero un “uomo” e la porta era quella del carcere di Regina Coeli.
La scienza non può lavarsi le mani ed accettare una pratica omicida solo perché rientra nelle dinamiche sociali: bisogna andare contro queste pratiche con convinzione. L’altra metà del cielo non deve accettare supinamente il ruolo di carnefice per realizzarsi. Oggi purtroppo la cultura vilmente minimizza la gravità dell’aborto, cercando di alleggerire al massimo il peso di un gesto tanto tragico, ma la tranquillità che si ottiene in cambio di questa complicità ha conseguenze profonde gravi non solo sulla donna che ne è tra le vittime principali, ma anche sul resto del tessuto sociale.